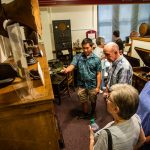PREMESSA
[Redatta nel 1996, la Premessa allo Statuto riprende e aggiorna quella scritta da Bosio e Cirese nel 1966 alla fondazione dell’IEdM]
L’Istituto Ernesto de Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario è stato fondato nel 1966 per iniziativa di Gianni Bosio (1923-1971) e Alberto Mario Cirese.
In funzione dal primo gennaio 1966, in esso sono confluiti e confluiscono i risultati delle ricerche sul campo di numerosi studiosi.
Archivio sonoro specializzato che ha pure raccolto materiali di ogni genere riguardanti le culture del mondo popolare e proletario, assumendo quindi aspetto multimediale, l’Istituto è stato ed è soprattutto un laboratorio per l’analisi del comportamento sociale passato e presente del mondo oppresso e antagonista (modi di produzione, forme sociali derivate e dinamiche che ne scaturiscono, processi di trasformazione e di ricomposizione della classe), per la valorizzazione delle culture orali e in particolare per la loro utilizzazione critica negli studi storico-socio-antropologico-linguistici e all’interno della società tutta.
La mondializzazione del sistema economico occidentale, l’integrazione politica e ideologica di buona parte del pianeta insieme all’accrescimento della dipendenza delle aree “deboli” da quelle “forti”, la tendenza all’uniformazione dei modi di vita e delle culture indeboliscono o dissolvono le alterità cui l’antropologia era solita rivolgere l’attenzione. Ma altre se ne ricostruiscono, spesso altrettanto radicali, nella forma di antiche alterità che resistono contaminandosi con la modernità o in quella della moltiplicazione dei particolarismi nel cuore stesso delle società occidentali. Nondimeno è vero che nozioni come alterità, sguardo esterno, osservazione partecipante, mondo popolare e proletario, classe, richiedono di essere riesaminate alla luce delle trasformazioni degli ultimi decenni.
Quindi, i punti di partenza nel lavoro di ricerca proprio all’Istituto, non possono che essere oggi due e strettamente legati: l’osservazione, la ricerca diffusa, l’analisi dei dati resi disponibili da una raccolta fatta anche con margini di casualità e senso del contingente; e, come unico insieme con questa osservazione e ricerca diffusa, una costante messa in discussione di tutte le grandi categorie e della loro assunzione come date: solo rirapportandole tutte alla realtà si può avviare un processo di loro verifica ed eventualmente di loro adeguamento o sostituzione. Solo così potrà forse prendere forma un qualche nuovo paradigma teorico.
In particolare, di fronte a uno sviluppo sociale transculturale, l’Istituto si propone una critica rigorosa di:
- tutti quegli approcci che tendono a perpetuare la visione esotica degli altri, anche sotto forma della “autenticità” nell’illusione della preservazione delle culture altre “così come sono” o sotto forma della scoperta dell’esotico dentro la stessa metropoli;
- delle categorie di osservazione “etnocentriche” e “androcentriche”.
Anche categorie come “mondo popolare e proletario”, “alterità” e “classe” in questo momento debbono essere assunte provvisoriamente, in vista di una loro ridefinizione o magari di un loro definitivo abbandono a vantaggio di altre più utili allo sviluppo della ricerca oggi.
“Mondo popolare e proletario” e “alterità” sono stati da sempre concepiti nel lavoro dell’Istituto strettamente correlati a “classe”, intesa come una formazione sociale e culturale che nasce e si trasforma nella realtà attraverso processi che si possono studiare solo nel loro svolgersi nel tempo e come punti d’arrivo provvisori di processi sociali prolungati. La classe va quindi sempre considerata come il punto d’arrivo di un processo storico reale. Lo studio di questo processo, che è stato sempre l’obbiettivo centrale dell’Istituto, in questa fase di macroscopiche trasformazioni sia del capitale sia del lavoro salariato, è più che mai indispensabile per la ridefinizione delle categorie.
“Classe” diventa quindi anche una categoria euristica e analitica da utilizzarsi badando a condurre non solo l’analisi sulle vecchie forme di aggregazione, ma guardando con curiosità e attenzione soprattutto alle nuove forme di aggregazione in fieri. Sarà quindi cura dell’Istituto condurre ricerche e analisi permanenti sulle trasformazioni interne al mondo del lavoro e alle sue forme associative, sui fenomeni indotti dall’immigrazione, dalla sottoccupazione (lavoro temporaneo, saltuario, flessibile) e dalla disoccupazione, non trascurando la ricerca di ogni forma di alterità, proponendosi di fissare realtà antiche e nascenti in molti luoghi e in diverse situazioni d’Italia.
La ricerca condotta su fonti orali e fonti scritte resta nel lavoro dell’Istituto il momento di organizzazione di una interdisciplinarietà che include e rapporta tra loro quel campo variamente e incertamente definito come etnologia, etnografia, antropologia, folklore ecc., quell’altro non più nettamente distinguibile dal primo che è possibile definire come “sociologia critica” e quello della storia. La negazione delle tradizionali divisioni disciplinari tra questi campi e, all’interno della storia, tra storia “grande” e trapassata, e “piccola” e presente, è stata e rimane una costante nel lavoro dell’Istituto. Questa posizione è stata particolarmente feconda di risultati, dando vita alle prime elaborazioni storiche condotte con l’uso critico di fonti orali.
Non è questo il solo terreno su cui le prospettive e le speranze poste a fondamento dell’Istituto si sono inverate. Negli ultimi decenni le società industriali e i loro settori più avanzati sono venuti a essere sempre più inestricabilmente inseriti in un sitema di relazioni con altri tipi di società o ciò che ne resta, per cui diviene sempre più difficile distinguere urbano e industriale da rurale e tradizionale. E infatti parte dell’antropologia e della sociologia lavorano oggi in direzione di una unificazione dei loro oggetti di ricerca e per la sperimentazione di metodi complementari di lavoro, obbiettivo che è pure di taluni etnostorici, etnomusicologi, etnopsicanalisti, etnopsichiatri, psicologi cognitivi, linguisti ed economisti, a confermare che i processi di interpenetrazione tra discipline diverse si sono progressivamente ampliati. Per molti studiosi l’antropologia ha smesso di essere la scienza delle “società esotiche” per diventare riflessione critica trasversale su qualunque società. È sempre più un’antropologia “del noi”, che assume a proprio oggetto gli stessi dislivelli di cultura della società di appartenenza, studiando l’insieme delle situazioni di alterità e diversità ovunque si manifestino, interessandosi alla vita quotidiana, alla socialità, alla cultura e ai rapporti simbolici che conferiscono senso alla vita dei gruppi, prendendo le distanze dalle realtà istituzionali per aprirsi a problematiche nuove man mano che va scoprendo i principi di organizzazione della società che studia (per esempio, una comunità rurale, un quartiere urbano, un grande complesso ospedaliero, una fabbrica, un settore di lavoro, una prigione ecc.). E ciò fa guardando non solo a quanto è permanenza ed equilibrio ma anche a quanto è dinamismo, rottura, strappo, opposizione.
In ambito sociologico si indagavano ormai con sempre maggior frequenza non solo le società metropolitane, con i loro mutevoli squilibri interni, ma anche le società periferiche, adottando l’osservazione partecipante e l’analisi qualitativa delle pratiche sociali. In particolare, talune sue correnti si sono sempre più preoccupate di osservare e analizzare le pratiche sociali e le culture orali sia nei microcosmi che nella società globale (sociologia delle espressioni della cultura popolare che si sforzano di cogliere e valutare le rotture, le sovversioni e gli spostamenti compiuti da tali espressioni in rapporto alle logiche dominanti; sociologia delle controculture; sociologia della critica della vita quotidiana; sociologia dei riti quotidiani di interazione, ecc.).
Parte degli storici, con il loro progressivo allargamento d’orizzonte dalle realtà istituzionali alle masse e ai fenomeni sociali, con la dilatazione del proprio operare alla “lunga durata” e il restringimento alla “brevissima durata” ( la cosiddetta “storia immediata”), con la ormai acquisita consapevolezza che per comprendere la società e fare buona storia occorre padroneggiare i discorsi che vengono fatti su di essa dai gruppi dirigenti o di opposizione che ne fanno parte, andando cioè al di là dei discorsi e delle pratiche dominanti e prendendo in esame dati “sommersi” e apparentemente marginali, sono sempre più portati a occuparsi di argomenti che in passato erano per lo più oggetti privilegiati di antropologia o sociologia.
In tutti questi processi di ricerca ha trovato ampia conferma la fondamentale indicazione, che è anche nella “tradizione” dell’Istituto, relativa alla necessità dell’osservazione ravvicinata per esplorare le soggettività attraverso il contatto diretto e la raccolta di testimonianze orali. Solo dalla valorizzazione del contributo delle persone con cui lavoriamo nella ricerca sul campo alla conoscenza di sé e del loro mondo e attraverso la riflessione critica sul ruolo stesso del ricercatore, si può arrivare, nei diversi campi, a temperare la “scienza sociale dell’osservatore”, ponendo in una prospettiva storica il suo oggetto d’indagine e assumendo la distanza necessaria per una sua valutazione comparativa e una sua apertura all’universale.
Nel complesso si può dire che le ragioni che avevano portato alla creazione dell’Istituto si sono dimostrate fondate e quindi esso mantiene ancor oggi la fisionomia di un organismo che – come scriveva il suo fondatore – “ricerca, raccoglie, ordina, elabora, utilizza il complesso delle manifestazioni della cultura orale di tutto il mondo popolare e proletario.
Un taglio diverso, un rapporto diverso escluderebbe le contraddizioni che esistono nel mondo popolare e delle classi: taglierebbe l’Istituto fuori dalle fonti, dalle matrici, dai canali conduttori che rappresentano l’asse, forse più importante, per arricchire sul versante della spontaneità della ricerca i materiali che l’Istituto va allineando”.
Compito dell’Istituto e dei gruppi a esso collegati è anche quello di obbiettivare con la ricerca le emersioni che provengono dal mondo popolare e dal proletariato. La ricerca non può rimanere fine a se stessa, aggiungeva infatti Bosio, il che equivale a dire che “la conoscenza delle condizioni di lavoro, delle forme dello sfruttamento collegata alla lotta per trasformare una condizione soggetta, si lega dunque a un certo tipo di ricerca, di popolarizzazione e di intervento. Non vi è condizione di lavoro e di sfruttamento che non sia legata al suo proprio intervento, un intervento che lo stesso operaio conosce e indica. Si tratta di provocare queste situazioni e questo atteggiamento e di renderli comuni collegandoli”. In altre parole, l’Istituto deve assicurare le condizioni indispensabili per verificare le esperienze e per metterle a frutto, continuando a proporsi come luogo ideale e organizzativo nel quale liberamente possano convergere, confrontarsi e integrarsi i risultati e i progetti così delle analisi conoscitive come della ricerca sul campo e più in genere della documentazione e della loro comunicazione. Un luogo dunque di sperimentazione reale di indirizzi, di tecniche e di metodi: non un istituto già fatto ma da farsi nella ricerca concreta. Suo compito è inoltre, da una parte, quello di rendere più largamente note e utilizzabili quelle infrastrutture documentarie e strumentali in grado di incrementare le ricerche cui si applicano l’Istituto e le forze che in esso convergono e, dall’altra parte, di dare il massimo di circolazione possibile ai risultati di conoscenza e di metodo cui i ricercatori pervengono. E di proporre alcuni indirizzi generali come ipotesi di lavoro alla cui verifica possano collaborare i gruppi di interesse, le specifiche competenze e i settori di indagine in cui l’Istituto intende articolarsi.
Le infrastrutture documentarie e strumentali dovranno essere costituite non soltanto dalla ordinata e razionale conservazione e dagli inventari dei risultati delle rilevazioni sul campo e più in genere delle ricerche passate e future dei collaboratori dell’Istituto, ma anche dall’approntamento e dalla pubblicazione di raccolte sistematiche, di indici analitici, di repertori ragionati del materiale documentario che gli studi italiani o stranieri sono venuti mettendo in luce in questo o quel settore specifico e di significativo interesse.
Le ipotesi di lavoro che costituiscono l’oggetto centrale delle verifiche che l’Istituto intende promuovere possono così enunciarsi:
- la condizione essenziale per ogni ulteriore utilizzazione teorica e pratica del patrimonio concettuale ed espressivo del mondo popolare e proletario è costituita da un attacco conoscitivo metodologicamente rigoroso e finalizzato a cogliere la realtà al di là delle mascherature ideologiche e mistificatorie e attento a non isolare arbitrariamente l’oggetto della ricerca dal contesto storico globale in cui si inserisce;
- la garanzia contro i rischi delle mescolanze promiscue tra ricerca conoscitiva e riproposta ideologica non è costituita dalla astratta separazione dei due momenti, ciascuno chiuso in una sua pretesa autonomia, ma sta invece in un rapporto dialettico che, ove se ne abbia profonda consapevolezza, fa sì che la ricerca pura si traduca in impegno e l’impegno in scienza;
- l’impegno civile che ha sostanziato di sé i momenti più importanti della lunga tradizione di ricerche sul mondo popolare e proletario si esprime, oggi, come rifiuto di accettare passivamente le operazioni di organizzazione dei consensi che si attuano soprattutto attraverso i grandi canali di comunicazione di massa; come contestazione attiva della pretesa del potere e dei gruppi egemonici odierni di imporre unilateralmente i propri modelli culturali e di sottomettere integralmente la produzione di cultura alle leggi del mercato e alla logica del profitto; come comunicazione scientifica oppositiva di documenti diretti e di analisi critiche che rompano l’esclusivismo culturale ufficiale; come proposta di nuovi prodotti di cultura consapevolmente legati al recupero del fondamentale carattere oppositivo che anima modi e forme del mondo popolare e proletario.
Infine: momento importante di una difesa della memoria del mondo popolare e proletario è anzitutto il garantirne la perpetuazione di fronte ai tentativi di distruzione che vengono operati da gran parte della industria culturale e delle istituzioni (per esempio, a tutt’oggi non esiste una legge che tuteli il patrimonio orale o audiovisivo alla stregua di quello cartaceo).
Per l’attuazione di questo programma di ricerche e verifiche l’Istituto provvederà, come suo compito istituzionale, all’approntamento delle strutture organizzative, documentarie e strumentali; alla utilizzazione delle competenze specifiche che, al di fuori dell’Istituto, appaiano necessarie per l’organico approfondimento delle ricerche; alla più larga disponibilità possibile (ed eventualmente anche alla ricerca) dei documenti necessari ai progetti perseguiti; alla programmazione di ricerche sistematiche da condurre in proprio o da affidare a collaboratori qualificati, e all’appoggio a iniziative personali o di gruppo che giudichi meritevoli; alla creazione delle condizioni e delle occasioni per il confronto, la discussione e lo scambio delle esperienze e dei risultati di lavoro dei gruppi o dei singoli che aderiscono all’Istituto, e per la verifica complessiva della validità o meno delle ipotesi di lavoro e della struttura organizzativa dell’Istituto nel suo complesso; all’apprestamento dei dischi, audiovisivi, libri, spettacoli, concerti, film, convegni, ecc., ritenuti utili per lo sviluppo del lavoro dell’Istituto.
Statuto dell’Associazione
ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO PER LA CONOSCENZA CRITICA E LA PRESENZA ALTERNATIVA DEL MONDO POPOLARE E PROLETARIO – Ente del Terzo Settore, o per acronimo ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO – ETS
Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS») è costituita l’Associazione denominata «ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO PER LA CONOSCENZA CRITICA E LA PRESENZA ALTERNATIVA DEL MONDO POPOLARE E PROLETARIO – Ente del Terzo Settore» o per acronimo «ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO – ETS» (di seguito anche «Associazione IEDM»).
L’Associazione IEDM ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo amministrativo. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione IEDM ha durata illimitata.
I fondamenti teorici, politico-culturali e scientifici dell’Associazione IEDM sono ispirati ai valori della Costituzione nata dalla Resistenza e sono quelli a suo tempo esposti nella premessa allo statuto della fondazione del 1966 scritta da Gianni Bosio e Alberto Mario Cirese e nella premessa allo statuto del 1997.
Art. 2
SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione IEDM non ha alcun fine di lucro, ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell’art. 5 del CTS, lettere F, I e V, proponendosi, in particolare, di:
- promuovere e condurre con ogni mezzo la ricerca delle varie forme dell’espressività popolare e proletaria;
- conservare il materiale raccolto in un apposito archivio specializzato, ordinarlo, descriverlo e valorizzarlo;
- svolgere e promuovere con ogni mezzo ogni iniziativa collegata alla conoscenza critica e alla presenza alternativa del mondo popolare e proletario.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione IEDM promuove e svolge, in proprio o avvalendosi di risorse esterne, attività di ricerca, di studio, di elaborazione, catalogazione e diffusione di materiali, prodotti e servizi, in qualsiasi forma, ivi compresa la promozione, l’organizzazione e la effettuazione di ricerche, convegni, corsi, seminari, spettacoli; la produzione, pubblicazione, rappresentazione e diffusione di materiali scritti, sonori, iconografici e audiovisivi su supporto cartaceo, ottico, elettronico e magnetico e comunque realizzati con ogni altro mezzo attualmente conosciuto o che possa essere scoperto in futuro. Promuove inoltre, nelle forme ritenute più opportune, contatti, intese, accordi anche operativi, sia a livello nazionale che internazionale con enti, associazioni, gruppi locali o persone singole che perseguano, in tutto o in parte, fini analoghi o complementari a quelli dell’Associazione IEDM.
Promuove anche la nascita di gruppi e associazioni affiliate all’Associazione IEDM.
Art. 3
ATTIVITÀ DIVERSE
L’Associazione IEDM può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 4
FONDO DELL’ASSOCIAZIONE E RACCOLTA FONDI
Il fondo dell’associazione è costituito:
- dai contributi e dalle quote dei soci fondatori e ordinari;
- dai proventi derivanti dall’attività associativa;
- dai contributi volontari, lasciti, donazioni, erogazioni, e da ogni altro contributo corrisposto all’Associazione sia da Enti privati che pubblici, istituti di credito, enti in genere nonché da ogni altra entrata che concorra a determinare l’attivo sociale.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione IEDM può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, di cui all’art. 7 del CTS e ai relativi provvedimenti attuativi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 5
FONDI E PROVENTI
I fondi e i proventi dell’Associazione IEDM sono costituiti da:
- le quote di associazione, di iscrizione e di contribuzione dei soci;
- contributi pubblici o privati;
- i reperti derivanti dal perseguimento degli scopi statutari;
- gli eventuali proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- gli eventuali proventi derivanti dalle attività diverse, di cui all’art. 3;
- i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi, di cui all’art. 4;
- i beni e le attrezzature utilizzati per il perseguimento degli scopi sociali;
- lasciti e donazioni di qualunque genere purché accettati dagli organi sociali;
- le giacenze e i depositi presso banche, istituti di credito, uffici postali e simili.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, primo comma.
Art. 6
BILANCIO
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Per la redazione del bilancio di esercizio e per ogni altro aspetto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 del CTS.
Art. 7
SOCI
Possono aderire all’Associazione IEDM le persone fisiche di qualunque nazionalità, purché maggiorenni, e le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono e fanno propri i principi e gli scopi dell’Associazione stessa e partecipano regolarmente alla sua attività. I soci sono soggetti al pagamento di una quota annuale.
La domanda di ammissione delle persone fisiche deve essere indirizzata al/alla Presidente, in forma scritta, e deve contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Per l’ammissione all’associazione delle persone giuridiche il Consiglio direttivo adotta un apposito modulo di adesione.
Sulle domande di ammissione di nuovi soci delibera l’Assemblea, a maggioranza semplice. In caso di rigetto della domanda, il/la Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’Assemblea può deliberare su proposta di almeno cinque dei suoi membri la nomina di soci onorari, tra persone fisiche che hanno conseguito particolari meriti su scala nazionale o internazionale nel campo delle ricerche e degli studi inerenti agli scopi dell’Associazione IEDM. I soci onorari possono essere chiamati a far parte della Consulta scientifica e non sono tenuti al pagamento di quote.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione IEDM, a partecipare con diritto di voto all’Assemblea, a eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, a essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; a concorrere all’elaborazione del programma di attività; a prendere visione dei bilanci e dei libri associativi, previa domanda scritta al/alla Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni dalla richiesta, e a usufruire dei servizi offerti dalla stessa e dell’accesso alle sedi e ai materiali conservati presso l’Associazione IEDM, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea. La presa visione dei libri sociali è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.
La qualità di socio viene meno, oltre che per morte,
- per il mancato versamento, entro le scadenze fissate, dei contributi e/o delle quote di associazione, di iscrizione o di contribuzione dovute;
- per recesso che va comunicato in forma scritta dalla socia o dal socio al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote e contributi già versati;
- a seguito di delibera motivata dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti lesivi per l’immagine dell’Associazione IEDM o di nocumento per il regolare svolgimento della sua attività. Il provvedimento di esclusione pronunciato dall’Assemblea è inappellabile.
Art. 8
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione IEDM:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Consulta scientifica;
- l’organo di controllo (se previsto).
Art. 9
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote associative; si riunisce, su convocazione del/della Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio Direttivo o un quarto soci degli associati.
La richiesta di convocazione e la convocazione, da diramare almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, devono indicare, attraverso la comunicazione ai soci di un ordine del giorno, i punti su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione — che potrà avere luogo anche nello stesso giorno della prima — quale che sia il numero dei soci presenti.
Gli associati potranno farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato delegato per scritto. Nessun associato potrà essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione IEDM o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vicepresidente, se nominato/a, o dal socio più anziano di età tra i presenti. Delibera di norma a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. L’assemblea dei soci si riunisce, di norma, in presenza. In casi eccezionali può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza ovvero in forma mista, con accertamento dell’identità di chi partecipa da remoto.
Di ogni riunione dell’assemblea, ivi compresa dell’assemblea straordinaria, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 10
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Sono compiti dell’Assemblea:
- eleggere il/la Presidente;
- determinare il numero, non inferiore a cinque, ed eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
- nominare l’organo di controllo se previsto;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 comma 1 del CTS;
- approvare gli indirizzi programmatici di attività;
- approvare il regolamento interno per l’accesso ai materiali custoditi dall’Associazione IEDM e per la loro utilizzazione;
- deliberare l’ammissione dei soci e la nomina dei soci onorari;
- stabilire ogni anno, per l’anno successivo, le quote minime annuali di associazione, di contribuzione o di iscrizione, su proposta del Consiglio direttivo;
- approvare le modifiche statutarie e decidere lo scioglimento dell’Associazione IEDM, determinandone le modalità e provvedendo alla devoluzione del fondo associativo residuo;
- fissare ogni anno per l’anno successivo l’eventuale compenso dovuto al/alla Presidente.
Art. 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata con le modalità di cui all’art. 9, primo comma, per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto o dell’atto costitutivo o allo scioglimento dell’associazione.
Per l’approvazione di modifiche all’atto costitutivo e allo statuto è richiesta la presenza, in prima convocazione, anche per delega, dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti; in seconda convocazione la presenza di 1/4 (un quarto) degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Art. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota associativa e dura in carica tre anni. La carica è gratuita.
Si applica l’art. 2382 del Codice civile.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo disciplina e coordina l’attività dell’Associazione IEDM mettendo in atto gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea e intraprendendo tutte le iniziative necessarie; è convocato dal/dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque non meno di due volte l’anno e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente, se nominato/a, o da altro/a Consigliere individuato/a tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, di regola con voto palese.
Di ogni riunione del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Per la pubblicità della nomina si applica l’art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- formulare proposte all’Assemblea in merito alle domande di adesione all’Associazione e all’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- formulare proposte all’Assemblea circa la determinazione dell’ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- nominare il direttore della rivista dell’Associazione;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal/dalla Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- deliberare in merito all’accettazione di lasciti o donazioni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può inoltre:
- nominare una/o o più vicepresidenti, un/una Direttore/Direttrice e un/una Segretario/Segretaria generale dell’Associazione;
- costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e le relative responsabilità, e stabilendo eventuali compensi.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, ovvero al/alla Direttore/Direttrice, se nominato/a, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 14
PRESIDENTE
Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione IEDM nei confronti di terzi e in giudizio e la rappresenta nelle sedi istituzionali e in generale nelle relazioni esterne. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Garantisce la linea e il livello culturale e scientifico dell’Associazione IEDM, ne assicura il regolare funzionamento e ne promuove lo sviluppo, in conformità alle finalità dello Statuto e secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea, avvalendosi della collaborazione operativa del Consiglio Direttivo, del/della Direttore/Direttrice e del/della Segretario/Segretaria generale, se nominati, e della consulenza della Consulta scientifica.
Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e, previa deliberazione del Consiglio direttivo, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il/la Presidente ha inoltre:
- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15
ORGANO DI CONTROLLO
Il controllo della gestione dell’associazione è affidato, a seguito di apposita delibera assembleare o al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, a un organo di controllo monocratico (Controllore Unico) scelto tra i soggetti qualificati di cui all’art. 2397 c.c., oppure a un organo collegiale (Collegio dei Controllori) composto di tre membri (di cui uno nominato Presidente) di cui almeno uno deve possedere i requisiti di cui al citato art. 2397 c.c..
L’organo di controllo svolge le attività di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, redigendo apposita relazione da sottoporre all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
L’organo di controllo svolge anche attività di revisione legale ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, superati i limiti previsti dal citato articolo.
Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
L’organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Esso dura in carica per tre esercizi annuali e può essere rieletto.
Art. 16
LA CONSULTA SCIENTIFICA
La Consulta scientifica è formata dai soci onorari e da membri eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La Consulta fornisce pareri in merito all’impostazione e all’orientamento culturale e scientifico dell’Associazione IEDM, ai suoi rapporti con la comunità scientifica e accademica nazionale e internazionale, nonché sul programma di lavoro annuale e pluriennale dell’Associazione stessa. Di tali pareri il/la Presidente dell’Associazione IEDM riferisce all’Assemblea perché questa ne tenga il dovuto conto nelle proprie deliberazioni.
La Consulta può nominare tra i suoi componenti un/a coordinatore/coordinatrice, che assicura il collegamento con gli altri organi sociali.
Di ogni riunione della Consulta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal coordinatore o, se non nominato, dal componente più anziano e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta scientifica, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 17
DIRETTORE/DIRETTRICE
Il Consiglio direttivo può nominare un/una direttore/Direttrice, che dura in carica tre anni, rinnovabili. Il/la direttore/direttrice:
- svolge funzioni di gestione corrente delle attività dell’associazione e ne garantisce la continuità, secondo i poteri che gli/le vengono attribuiti dal Consiglio direttivo;
- sovrintende all’archivio e alla biblioteca;
- coordina il personale e i collaboratori dell’Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio direttivo;
- collabora con il/la Presidente e con il Consiglio direttivo nella predisposizione degli atti istruttori relativi alle materie oggetto di deliberazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
- svolge tutti gli altri compiti che gli/le vengono affidati dal Consiglio direttivo e dal/dalla Presidente.
Il/la Direttore/Direttrice partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 18
SEGRETARIO/A GENERALE
Il Consiglio direttivo può nominare un/una Segretario/a generale, che si occupa della tenuta dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio direttivo o dal/dalla Presidente.
Art. 19
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’Associazione può inoltre ricorrere a volontari/volontarie che, condividendone lo spirito, prestino la loro opera in suo favore. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai/dalle volontari/volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Ai/alle volontari/volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei/delle volontari/volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale devono essere assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato. L’Associazione IEDM, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 20
LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze della Consulta scientifica;
- il libro dei/delle volontari/e, contenente i nominativi dei volontari/e che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal/dalla Presidente.
Art. 22
DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Firmato
Stefano Arrighetti
Riccardo Cambi Notaio